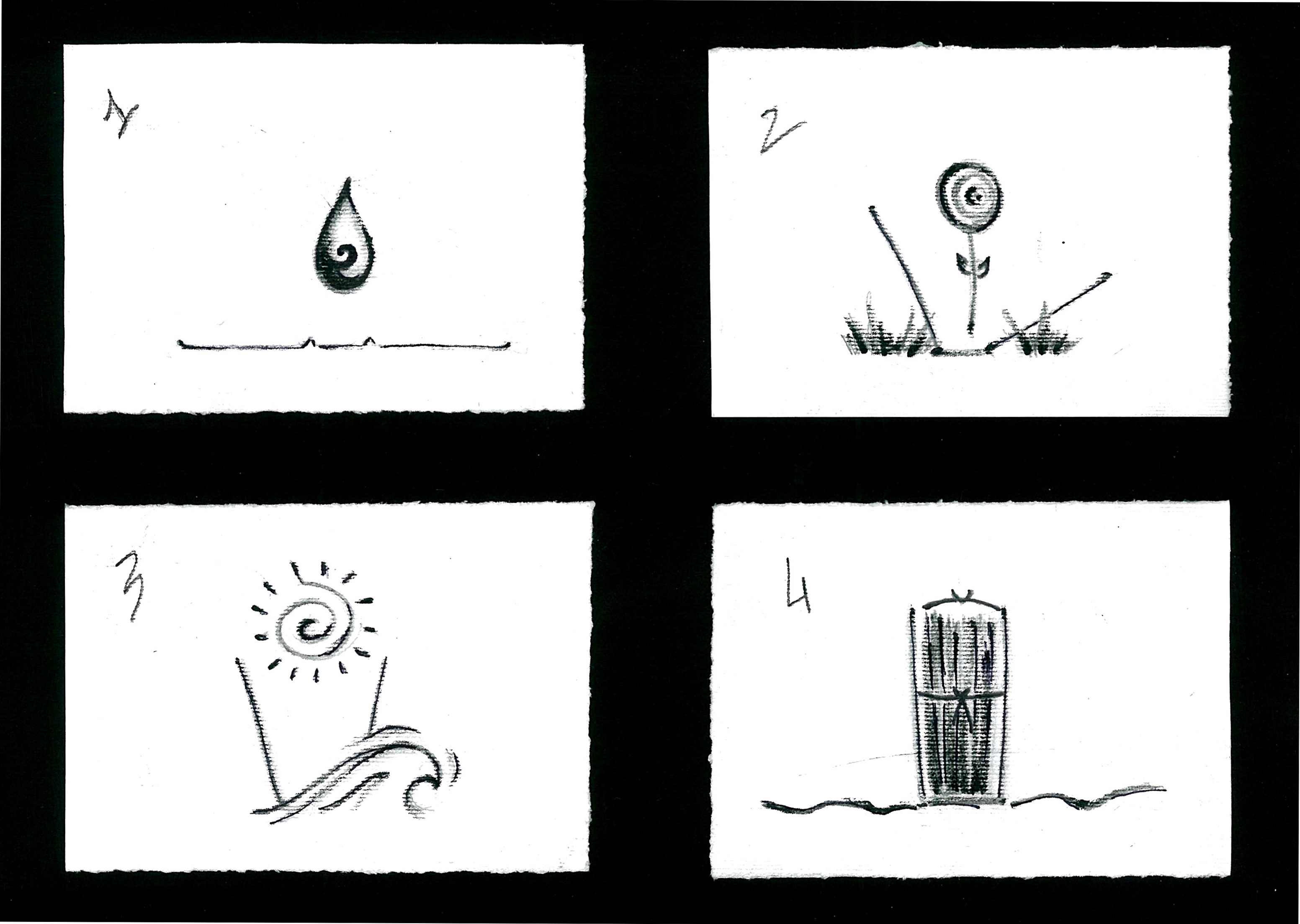Che cosa è un archivio?
Il termine <<archivio>> viene comunemente utilizzato ad individuare sia il luogo di conservazione dei documenti, sia l’ente preposto alla conservazione dei medesimi oppure il complesso documentario.
Nel linguaggio archivistico, in senso strettamente tecnico, l’archivio corrisponde al solo complesso documentario, con la sua duplice funzione giuridico-amministrativa e storico-culturale.
All’interno della disciplina archivistica, la definizione di <<archivio>> è da sempre oggetto di dibattito, con la conseguenza che anche la disciplina preposta al suo studio, conservazione ed ordinamento, ne risulta necessariamente coinvolta.
Di seguito si propongono alcune definizioni e riflessioni riguardanti l’archivio, l’archivistica e la figura dell’archivista.
Senza alcuna pretesa di esaustività, si vuole, qui, solo rendere, la complessità della materia.
Cesare Guasti (1870)
Successore e continuatore dell’opera di Francesco Bonaini presso l’Archivio di Stato di Firenze. Si propone la definizione di archivista da lui data, una professione che si basa sulla praticità e sul principio di avalutatività.
<<L’archivista non sceglie, non illustra, non confronta: inventaria tutto: i diplomi e le bolle come le più inutili carte: transunta dal primo all’ultimo documento d’una serie; né pensa se uno val più dell’altro, se un nazionale o uno straniero se ne gioverà. Serve alla storia, non si appassiona per nulla; e finito un registro ne prende un altro.>>.
Commissione Cibrario e R.D nr. 2552 del 27 maggio, artt. 1-23.
Viene esplicitato il principio del rispetto dei fondi e del metodo storico per il riordinamento degli archivi, senza stabilire criteri uniformi per l’ordinamento, nel rispetto della storia e della peculiarità degli enti produttori, sulla scorta dell’elaborazione teorica del metodo storico di Francesco Bonaini e della scuola Toscana.
<<VITTORIO EMANUELE II PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA Veduto il regio decreto 26 marzo 1874, n. 1861; Udito il consiglio per gli archivi; Udito il consiglio di Stato; Udito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del nostro ministro segretario di stato per gli affari dell’interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Gli atti dei dicasteri centrali del Regno, che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in unico archivio, il quale ha titolo di Archivio del Regno. Art. 2 Gli atti dei dicasteri centrali degli Stati che precedettero al Regno d’Italia sono raccolti nell’archivio esistente nella città che fu capitale degli Stati medesimi. Art. 3 Gli atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali del Regno che piú non occorrono ai bisogni ordinari del servizio e quelli delle magistrature, amministrazioni, corporazioni cessate, sono raccolti nell’archivio esistente nel capoluogo della provincia nella quale le magistrature, le amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano sede. Art. 4 Negli archivi si conservano pure tutti gli atti appartenenti in libera proprietà allo Stato, che hanno carattere di documento pubblico o privato nel senso giuridico e diplomatico della parola. Art. 5 Gli atti dei dicasteri centrali dei Governi cessati costituiscono una sezione di archivio che si dice degli atti di Stato. Art. 6 Gli altri atti archiviati vanno ripartiti in tre sezioni, cioè degli atti giudiziarii, degli atti amministrativi, degli atti notarili. Cogli atti che non provengono da magistrature, da amministrazioni, da notai, sono costituite sezioni speciali. Art. 7 Gli atti di ciascuna sezione sono disposti separatamente per dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, notaio, famiglia o persona, secondo l’ordine storico degli affari o degli atti.
Art. 8 Di tutte le carte costituenti l’archivio viene fatto inventario, da cui risulti il numero dei mazzi o volumi e quello degli atti contenuti, notando se siano originali o copie. Senza il parere del consiglio per gli archivi, nessuno scarto può farsi degli atti scritti sull’inventario. Art. 9 Per ogni sezione deve aversi un indice, e per ogni dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, o altra classe speciale, un repertorio degli atti relativi. Art. 10 Il consiglio per gli archivi stabilisce le regole per la compilazione degli inventari, degli indici, dei repertorii, dei regesti, e di ogni altro lavoro generale d’archivio. Art. 11 Gli atti conservati negli archivi sono pubblici, meno quelli confidenziali e segreti fino dall’origine, che contengono informazioni e giudizi di pubblici uffiziali sulla vita di determinate persone. Art. 12 Gli atti di politica esterna e concernenti l’amministrazione generale degli Stati con cui fu costituito il Regno sono pubblici sino all’anno 1815. I processi giudiziarii penali sono pubblici dopo settant’anni dalla loro conclusione. Gli atti amministrativi sono pubblici dopo trenta anni dall’atto con cui ebbe termine l’affare al quale essi si riferiscono. Art. 13 Gli atti che hanno carattere puramente storico, letterario o scientifico; le sentenze e i decreti dei magistrati; le decisioni e i decreti delle autorità governative e amministrative; gli atti dello stato civile delle persone; gli atti delle provincie, dei comuni e dei corpi morali occorrenti alla loro amministrazione; gli atti necessari allo esercizio dei diritti elettorali, alla prova dei servizi civili o militari, ed allo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato; sono pubblici qualunque sia la loro data. Art. 14 Degli atti che non sono pubblici può esser dato notizia con licenza dei ministri di giustizia, dell’interno, o degli affari esteri, secondo che essi atti siano giudiziali, amministrativi, o di politica esterna. Art. 15 Gli atti dei tribunali e degli uffici amministrativi, finché rimangono presso i medesimi, devono essere raccolti in unico locale per ogni magistratura od ufficio, ed affidati alla custodia di un solo impiegato. Nessuno di questi atti può per alcun motivo venire segregato dagli altri o levato dall’ordine generale della loro conservazione, meno gli stampati, i duplicati, e quelli che non hanno carattere di atto ufficiale, i quali, con licenza data per iscritto dal capo della magistratura o dell’ufficio, possono annualmente essere venduti o distrutti. Art. 16 Accadendo la morte di magistrati o funzionari pubblici, o di persone che abbiano avuto pubblici incarichi, massime diplomatici o ministeriali, presso cui fossero atti di proprietà dello Stato, sarà cura del prefetto della provincia di fare quanto sia necessario perché tali atti vengano trasferiti tosto nell’archivio, al quale spettano per ragione di materia o di luogo. Art. 17 Dagli archivi delle magistrature giudiziali o degli uffici amministrativi sono nei primi mesi di ogni anno levati gli atti concernenti affari compiuti da oltre dieci anni, e trasportati nell’archivio a cui spettano. Art. 18 Gli atti che hanno carattere di riservati possono rimanere presso l’ufficio dal quale emanarono fino a quando ciò sia creduto prudente, nell’interesse così del pubblico come dei privati, dal ministro da cui l’ufficio dipende. Art. 19 I registri delle sentenze giudiziali rimangono per trenta anni nelle cancellerie delle corti e dei tribunali da cui esse furono pronunziate. Art. 20 Nelle cancellerie dei tribunali rimangono pure gli atti di stato civile posteriori all’anno 1865, in conformità del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602. Art. 21 Avanti di scrivere sull’inventario le carte recentemente depositate, i direttori d’archivio esaminano se alcuna possa venire distrutta senza danno della storia o dell’amministrazione. Le proposte, col parere del capo dell’ufficio a cui le carte appartenevano, sono spedite al sovrintendente, che le trasmette col proprio avviso al ministro dell’interno, perché, udito il consiglio per gli archivi, decida sulle medesime. Art. 22 Gli archivi delle provincie, dei comuni, dei corpi morali, tutelati dal Governo od esistenti per virtù di legge, non che quelli delle curie diocesane e delle dignità ecclesiastiche pel tempo in cui esse esercitarono civile giurisdizione, devono essere custoditi ordinatamente dalla provincia, dal comune, dal corpo morale, dalla dignità ecclesiastica e sono soggetti alla vigilanza dei sovrintendenti. Art. 23 I sovrintendenti vigilano e fanno vigilare dai direttori perché nel territorio della propria giurisdizione, ponendosi in vendita documenti storici, carte antiche, o atti di pubbliche amministrazioni, siano denunziati gli abusi, rivendicate le carte pubbliche, acquistati per conto del Governo i documenti che interessano la storia o l’amministrazione. >>.
Il Manuale degli Olandesi (1898)
Archivio è solo quello di natura pubblica. L’archivio è concepito come un <<tutto organico>>.
<<Archivio è l’intero complesso degli scritti, disegni e stampe, ricevuti o redatti in qualità ufficiale da qualunque autorità o amministrazione, o da qualsiasi impiegato di queste, purché tali documenti, conformemente alla loro funzione, debbano rimanere presso la stessa autorità o amministrazione, o presso i suoi impiegati.>>.
<<Questa definizione dell’archivio, posta qui come base su cui si verrà costruendo tutto il resto, venne adottata all’unanimità tanto nella riunione della Società degli archivisti olandesi, quanto in quella degli archivisti di Stato d’olanda, e approvata dal Ministero olandese dell’Interno […]. Se generalmente è difficile giustificare una definizione, nel nostro caso potrebbe anche essere superfluo; non sarà tuttavia inutile chiarire un po’ i vari suoi punti, essendo necessario che la portata della definizione sia giustamente compresa sotto ogni rispetto, poiché naturalmente è da essa che derivano tutte le ulteriori considerazioni. [In particolare sul concetto di <<intero complesso>>] Nella discussione della definizione fu chiesto quando un archivio si possa chiamare una <<totalità>>, e se questa espressione sia giusta anche quando di un archivio rimangono soltanto alcuni documenti. A ciò si è risposto che l’archivio è una <<totalità>>, in quanto che non è una <<parte>>, ossia in quanto non si sappia che vi sieno altrove altre parti dell’archivio stesso. Se vi sono, è opportuno cercare in ogni modo di ricostruire con queste parti l’intero complesso; ma se di un archivio si è conservato anche soltanto un documento, allora questo solo costituisce di per sé l’archivio; esso rappresenta da solo una totalità, e si deve anche descrivere come tale.>>.
(S. MULLER FZ. J. A. FEITH-R. FRUIN TH. AZ., Ordinamento e Inventario degli Archivi, Torino, Un. Tip. Ed. Torinese, 1908, p. 1-2)
Ezio Sebastiani (1904)
Si osservi l’utilizzo improprio del termine <<raccolta>> e la possibilità che l’archivio sia originato anche da un ufficio <<privato>>, non viene, però, specificata la possibilità che un archivio possa originarsi privatamente da una persona.
<<[L’archivio è] una raccolta ordinata di documenti a scopo di amministrazione nel senso più lato, esistente o esistita, e che perciò possono emanare sia da una magistratura, sia da un ufficio pubblico o privato.>> .
Friedrich Kuch (primi del ‘900)
Si osservi la differenza rispetto alla definizione del Sebastiani, dove l’archivio può essere originato da una famiglia o da una persona singola.
<<Un archivio è la totalità dei residui scritti, destinati a duratura conservazione, organicamente prodotti nella gestione degli affari o nel rapporto privato, di un’autorità, corporazione, famiglia o singola persona.>>.
Pio Pecchiai (1911)
Si riporta questa prima definizione di archivio del Pecchiai (ne seguirà una seconda nel 1928) dove si comprende la definizione di archivistica data dallo stesso Pecchiai a cui fa riferimento Barone nell’annotazione successiva.
<<[L’archivio è] una raccolta di documenti e carte varie, volumi, protocolli e registri che vengono accumulandosi per qualche causa della vita sociale e che poi si conservano per una utilità propria.>>
Nicola Barone (1916)
Sulla necessità degli archivisti di confrontarsi sulla nozione di archivio e di conseguenza su quella di definire la disciplina archivistica.
<<V’ha dunque fra i collaboratori della Rivista [Gli Archivi italiani] chi afferma, che tutti i trattati di archivistica cominciano con la definizione degli archivi in generale, e si domanda se sia possibile definire l’archivio, e soggiunge che la risposta vien data da tutti gli autori, che si sono occupati dell’argomento, criticandosi spesso ferocemente e giustamente fra loro; soggiunge ancora, che senza affannarsi tanto a definire l’archivio sarebbe bastato rileggere la circolare del Ministero dell’Interno, del luglio 1882, là dove è scritto, che gli archivi racchiudono le testimonianze dei diritti pubblici e privati e di tanta parte di storia nazionale[…]. Ed ecco ancora un’altra quistione mossa dai due collaboratori, de’ i quali ho fatto cenno[…].E’ dunque tanto difficile definire l’Archivistica? Dalle opere dei trattatisti, dai programmi recenti d’insegnamento e d’esame non si desume forse in che consista la nostra disciplina? E il Paoli, il primo paleografo italiano, ci disse forse, che cosa fosse la Paleografia? Qualcuno potrà rispondermi esser facile intenderla: è l’arte o dottrina della scrittura antica; ma la Paleografia concerne solo la scrittura? Di alcune discipline, scienze, dottrine non si può, in verità, comprendersi la definizione, se non si esamini o studi il contenuto di esse; il definire è opera di deduzione non d’induzione e va compiuta dallo studioso. La filologia p.e. è la scienza della lingua: basta forse questa definizione per avere un concetto chiaro, preciso, esatto di tale dottrina? Perciò la più semplice, elementare definizione dell’Archivistica: Dottrina degli Archivi è riprovata dal primo dei due collaboratori, forse perché poco comprensiva o perché olezza troppo, secondo alcuni, pute, secondo altri di germanismo (Archivlehre). Il buon Pecchiai definì l’Archivistica: La dottrina, che insegna a bene ordinare ed a conservare un archivio. Questa definizione potrebbe sembrare incompiuta: mi permetto di proporne un’altra: è la disciplina, che insegna a conoscere la struttura, l’essenza, la storia degli archivi, e ad ordinarli, a conservarli, ad amministrarli.>>.
(N. BARONE, Per lo studio dell’Archivistica. Memoria letta all’Accademia Pontiana nella tornata del 6 febbraio 1916, Napoli, R. Stab. Tip. Francesco Giannini & Figli, 1916, p. 12; pp. 13-14)
Eugenio Casanova (1928)
Uno dei massimi esponenti dell’archivistica a livello europeo, fu direttore degli Archivi d Stato di Torino, Napoli e Roma. Ottenne la prima cattedra di Archivistica in Italia, creata all’interno del la romana Facoltà di Scienze Politiche, quando si andava delineando un riconoscimento dell’importanza della disciplina archivistica per le scienze storiche ed economiche. La sua concezione dell’archivistica spinse, inoltre, la disciplina ad acquisire un ruolo proprio, separata dalla diplomatica e dalla paleografia, dalle quali era dipendente.
<<[L’archivio è] la raccolta ordinata degli atti di un ente o individuo, costituitasi durante lo svolgimento della sua attività e conservata per il conseguimento degli scopi giuridici, politici e culturali di quell’ente o individuo.>>
<<Rari sono, in Italia e altrove, coloro i quali sappiano che cosa sia un archivio; rarissimi, coloro i quali discernano a che cosa veramente serva. Ma, quantunque scarsi di numero, questi eletti costituiscono una forza; che, colle sue generose rampogne, frena, talvolta, lo scempio, che delle scritture, che lo compongono, vorrebbero incessantemente fare la trascuranza e la brutalità altrui. Questo scempio, però, è fatale, ineluttabile attraverso il tempo e lo spazio, come fatale è per tutto il creato: ciò che rende più squisita la lotta, che, in altri termini, per opera di quei pochi, contro la barbarie combatte la civiltà. Questa lotta si manifesta in tutti quegli accorgimenti , coi quali si raccolgono, si conservano e tramandano, si ordinano e utilizzano le memorie del passato e del presente, a benefizio della Società: accorgimenti, che richiedono una somma notevole di abnegazione e di austerità da coloro, i quali vi attendono. Con tali virtù questi individui rendono non scarsi servigi alla Società e alla scienza; ma, per quel senso indefinibile di scetticismo, che ne informa la vita, non si curano di strombazzarli, di esaltarli, né asseriscono di aver mai salvato il mondo: e, quindi, lasciano che altri ne approfitti, che tutti li dimentichino e ne ignorino persino l’esistenza. Ne conseguono l’abbandono, nel quale essi e il loro istituto sono generalmente lasciati, l’incomprensione, che tutta questa materia aduggia e, pur troppo, intacca persino la loro stessa fibra, sì da ridurli empirici cultori di dottrina, da tutti ignorata. Da questo processo di alterazione, che da tempo si svolge, sorge il problema dell’archivio, degnissimo dello stadio di civiltà, al quale siamo giunti; e a risolverlo ci proviamo colle pagine seguenti: nelle quali, forse con eccessiva presunzione, tentiamo cosa, a nostra conoscenza non mai sperimentata, vale a dire, l’affermazione di una nuova scienza.>>.
(E.CASANOVA, Archivistica, Siena, Stab. Arti Grafiche Lazzeri, 1928, pp. VI-VII)
Giorgio Cencetti (1937)
Esperto paleografo e diplomatico, ricoprì l’afferente cattedra prima presso l’Università di Bologna e poi presso la Libera Scuola di Scienze storiche di Verona, approdando, infine, alla Scuola speciale per bibliotecari e archivisti di Roma. In occasione del trattato di pace con la Iugoslavia, dopo la seconda guerra mondiale, fu incaricato dal Governo italiano, di curarne la parte riguardante la materia archivistica. Con lui si ha l’estremizzazione del metodo storico inaugurato dal Bonaini e dalla Scuola Toscana, esplicitando ed applicando in modo chiaro il vincolo archivistico e ponendo le basi per un’identità sostanziale tra archivio ed ente produttore (a questo riguardo si faccia anche riferimento agli scritti di Adolf Brenneke, Filippo Valenti e Claudio Pavone). Si delinea così anche il compito dell’archivista che non deve fare altro che <<seguire le carte>>. Personalmente trovo la teoria cencettiana estremamente affascinante.
<<[L’archivio è] il complesso degli atti spediti e ricevuti da un ente o individuo per il conseguimento dei propri fini o per l’esercizio delle proprie funzioni.>>.
<<Non esiste il problema dell’ordinamento. Non ce n’è che uno quello imposto dalla originaria necessità e determinatezza del vincolo archivistico […] le carte si ordinano da sé e l’archivista non deve fare altro che seguirle guardandosi attentamente da ogni arbitrio.>>.
Adolf Brenneke (1937/1953)
Proveniente dalla Scuola archivistica di Marburg, lavorò all’Archivio di Stato di Munster, Danzica e Hannover, del quale fu direttore dal 1923 al 1930, dedicandosi anche ad un’intensa attività scientifica, per poi ricoprire l’importante incarico di Secondo direttore dell’Archivio Centrale prussiano, ossia l’Archivio Segreto di Stato di Berlino-Dahlem, il più grande Archivio tedesco. Fu ideatore di una metodica archivistica innovativa attraverso un’elaborazione logica e chiara dove la storia egli archivi diventava la storia delle forme. Compito dell’archivistica e dell’archivista è indagare come i singoli documenti possano riunirsi in unità più grandi e come questo si sia verificato storicamente, nei diversi tempi. A lui si deve la rielaborazione del <<principio di provenienza>>, alla base di ogni ordinamento, nel <<principio di provenienza liberamente applicato>>, una soluzione intermedia tra il francese << respect des fonds>> e l’olandese principio di <<registratura>>.
<<L’archivio è la totalità degli scritti e di altri documenti che si sono formati presso persone fisiche o giuridiche in base alla loro attività pratica o giuridica e che, quali fonti documentarie e prove del passato, sono destinati a permanente conservazione in un determinato luogo.>>.
<<Noi vogliamo in quest’opera limitarci ad una trattazione approfondita dell’archivistica in senso stretto. A differenza dalla diplomatica dei documenti e da quella degli atti, questa disciplina non si occupa dei singoli documenti in sé considerati: essa si occupa piuttosto di indagare in quale modo questi documenti siano stati, col decorso del tempo, incorporati in un tutto organico, cioè in un archivio. Dopo questa ricerca sulla costituzione interna e quindi sulla struttura dell’archivio, c’è il secondo problema fondamentale, cioè quello della organizzazione degli archivi, ossia della loro relazione con gli altri uffici e della definizione della loro competenza. Una dottrina archivistica tuttavia, che non volesse dare nulla di più che ricette già pronte, cioè regole ad uso dell’archivista, sarebbe incompleta. Fa parte infatti della dottrina archivistica anche la storia archivistica, il cui studio, a nostro avviso, non può essere considerato come passione da antiquari. Senza la conoscenza della storia degli archivi, infatti, così come delle teorie archivistiche, i cui risultati per molti aspetti confluiscono certamente nell’attuale situazione storica, diventerebbe per noi incomprensibile la intrinseca costituzione di qualunque archivio. Una tale dottrina archivistica, basata sulla storia archivistica, ci insegna nello stesso tempo anche la strada per giungere alle fonti archivistiche. Essa tuttavia vuole essere più che una semplice dottrina delle fonti., se questa venga intesa come storia e descrizione del contenuto; deve invece, quale storia dei tipi morfologici, cercare di stabilire, in quali forme il contenuto si è espresso. Contenuto e forma, interno ed esterno, si appartengono reciprocamente.>>.
(A. BRENNEKE, Archivistica, Milano, Ed. Antonino Giuffrè, 1968, p. 22)
Elio Lodolini (1970)
Non si dimenticano Hilary Jenkinson, padre dell’archivistica inglese o Theodore Schellenberg, padre dell’archivistica americana e gli italiani: Antonio Panella, che oltre ad aver affermato l’archivio come un tutt’uno senza partizioni, pubblicò la celebre relazione di Bonaini al Ministro della Pubblica Istruzione del 1867 dove si formulava il principio del metodo storico per il riordino degli archivi; Leopoldo Sandri e la sua essenziale definizione di archivistica come la disciplina che <<studia il fatto archivio in tutte le sue significanze ed incidenze>>; Leopoldo Cassese ed il principio dell’avalutatività, dove, riprendendo Cesare Guasti, sottolineava come un archivio potesse servire <<tanto alla storia descrittiva quanto a quella problematica e tanto ad una ideologia conservatrice, quanto ad una ideologia rivoluzionaria>>. Per brevità, occorre fare però un salto temporale fino a Elio Lodolini la cui definizione di archivio è funzionale a mettere in luce un’altra problematica: la selezione dei documenti. Un archivio, in realtà, non prevede si possa selezionare arbitrariamente quali documenti si possano o meno conservare, in quanto viola il principio di avalutatività.
<<[L’archivio è] il complesso di documenti formatisi presso una persona fisica o giuridica (od un gruppo di uffici od organi di quest’ultima) –o anche aggiungiamo, di un’associazione di fatto- nel corso dell’esplicazione della sua attività e pertanto legati da un vincolo necessario, i quali una volta perduto l’interesse per lo svolgimento dell’attività medesima, sono stati selezionati per la conservazione permanente quali beni culturali.>>.
Filippo Valenti (1975)
Può essere considerato il massimo esponente teorico dell’archivistica per il Novecento. La sua riflessione parte dall’analisi degli scritti di Adolf Brenneke.
<<[L’Archivio è] il complesso delle scritture od altre forme di documentazione, prodotte e ricevute o comunque acquisite da un ente (istituto, ufficio, individuo o famiglia) durante l’esercizio dell’attività svolta per l’espletamento delle proprie funzioni e/o per il raggiungimento delle proprie finalità pratiche. Esso è conservato in genere dallo stesso soggetto che lo ha prodotto o dai suoi successori o aventi causa oppure da istituti all’uopo deputati dallo Stato (archivi in senso lato o di concentrazione), vuoi come memoria e strumento per la prosecuzione della suddetta attività, vuoi infine come patrimonio culturale nella misura in cui questi ultimi siano ritenuti fonti attuali o potenziali per la ricerca storica.>>.
<<Eppure pochissimi termini, a questo livello di impegno teoretico e in quest’ambito di interessi, sono stati fatti oggetto con altrettanta frequenza ed insistenza di esercitazioni definitorie e di tentativi di coglierne, come si suol dire, il concetto; di rispondere cioè alla domanda: che cos’è essenzialmente un archivio? […] Tutta quanta la dottrina ( e non soltanto essa, come vedremo) è intessuta di problematiche che una definizione sembrano sottintendere o postulare. […] La prima e più importante peculiarità del fenomeno archivistico è che un archivio non è mai una semplice somma, raccolta o collezione di documenti d’archivio, ma costituisce bensì, nel suo complesso, il residuo di un’attività di gestione di qualcosa, nella misura e nello stato di conservazione e di ordinamento in cui tale residuo ci sia stato tramandato da chi, o cosa, quell’attività era tenuto o aveva interesse a svolgere, e/o da chi cosa, in seguito abbia poi dovuto o ritenuto utile conservarlo. Ove per attività di gestione è da intendersi un insieme di atti ( termine non a caso di larghissimo uso nel linguaggio sia burocratico che archivistico) politicamente, giuridicamente, economicamente o comunque amministrativamente rilevanti, l’originaria e intrinseca correlazione coi quali –siasi essa concretata in un rapporto di diretta strumentalità o di strumentale memorizzazione- qualifica appunto come tali i singoli documenti d’archivio. Ne deriva che il tutto viene qui a tutti gli effetti prima delle parti, e non viceversa, come suole accadere nel caso delle biblioteche o dei musei; cosa che la dottrina ha inteso sottolineare […] sia col presentare l’archivio come organismo, sia col parlare del vincolo o nesso archivistico che ne collegherebbe uno all’altro gli elementi costitutivi, rimanendo operante quali che siano gli smembramenti e rimaneggiamenti che il complesso abbia poi eventualmente avuto a subire per estrinseche vicende.>>.
(F. VALENTI, Scritti e lezioni di archivistica diplomatica e storia istituzionale, Roma, pubblicazione a cura del Ministero per i beni e le attività culturali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000, pp.83-85)
Paola Carucci (1983)
Ricordiamo i prestigiosi incarichi di Consulente del Presidente della Repubblica per l’Archivio storico del Quirinale dal 2006 e dal 2008 la soprintendenza dell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica.
<<[L’archivio è] il complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti durante lo svolgimento della propria attività da magistrature, organi e uffici dello Stato, da enti pubblici e istituzioni private, da famiglie e da persone[…].>>.
<<Tra i documenti che compongono l’archivio esiste una connessione logica e formale che li collega tra loro mediante un vincolo di necessarietà che si suole chiamare vincolo archivistico.>>.
<<Non sono molte le persone che siano in grado di darvi una risposta adeguata alla domanda Che cosa sono gli archivi?. Da un lato, infatti, abbiamo gli archivisti e i ricercatori che ben conoscono- gli uni perché li conservano, gli altri perché li utilizzano- i documenti e gli istituti presso cui gli archivi vengono conservati. Dall’altro abbiamo le persone qualsiasi per molte delle quali forse ha ancora un senso il luogo comune di collegare gli archivi a un’idea di depositi inanimati e polverosi; spesso gli archivi rappresentano per molti soltanto quell’entità misteriosa con cui vengono in contatto quando hanno bisogno di reperire –spesso senza riuscirvi- un documento indispensabile per provare il proprio diritto a percepire la pensione o per ricostruire la continuità di un rapporto di lavoro o il periodo in cui si è prestato il servizio militare o per verificare i passaggi di proprietà di un terreno o di un fabbricato […]. L’archivio è il complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti durante lo svolgimento della propria attività da magistrature, organi e uffici dello Stato, da enti pubblici e istituzioni private, da famiglie e da persone […]. Naturalmente, gli enti diversi dalle autorità che esercitano poteri politici, amministrativi e giudiziari, vale a dire le istituzioni private, le famiglie e le persone che producono in dipendenza della loro attività documentazione, pongono anch’essi in essere degli archivi, ma non sono in linea di massima vincolati a quel complesso di norme giuridiche e tecniche previste per la formazione e la conservazione dei documenti appartenenti agli archivi degli organi che esercitano funzioni pubbliche. Questa distinzione […] non incide sull’unità sostanziale del concetto di archivio che nella sua formulazione generale può essere riferito a tutti gli archivi qualunque sia l’ente che li ha prodotti e l’epoca in cui si sono formati. Se pertanto il vincolo archivistico è più facilmente individuabile tra i documenti di un archivio che abbia una struttura complessa e un’articolazione precostituita sulla base di criteri giuridici e formali più rigidi, esso è presente, come connessione logica e formale (sia pure in modo più rudimentale) in ogni complesso di documenti formatosi per le finalità pratiche di un soggetto.>>.
(P. CARUCCI, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, Carocci Ed., 1998, p.11; pp.19-20)
Antonio Romiti (1990)
Professore di archivistica Generale e Storia degli Archivi presso l’università di Firenze. Personalmente trovo il suo modo di esporre la materia estremamente chiaro.
<<[L’archivio è] un complesso di scritture che, legate da un vincolo naturale, sono prodotte da entità pubbliche o private nell’espletamento della loro attività per il raggiungimento di finalità contingenti e per la conservazione della propria memoria.>>.
<<[…] Riteniamo che l’archivistica fondi la propria natura sopra generali e particolari principi teorici che ne corroborano le qualificazioni scientifiche, che non pochi aspetti gestionali trovino la loro ragione funzionale nella elaborazione di elementi dottrinari, così come non possiamo trascurare la presenza di prassi operative. Il vero problema di questa disciplina si trova racchiuso quindi nella necessità di comprendere e di definire la natura dell’archivio, poiché solamente partendo da tale concetto possono delinearsi gli aspetti sostanziali e formali che attengono all’oggetto dell’operare ed alle procedure comportamentali, da attuarsi nel rispetto di quei principi e di quelle regole che conducono alla conservazione ed alla gestione della memoria […]. L’archivio, inteso in senso proprio e nel suo significato strettamente tecnico, è individuabile in ogni complesso di scritture, realizzate dai singoli soggetti produttori a seguito e quale diretta conseguenza della sua spontanea e naturale attività rivolta verso la società esterna. Il materiale così ottenuto si distingue […] per la necessaria presenza di un vincolo naturale [involontario]che contribuisce a creare un particolare collegamento tra tutti i suoi elementi.>>.
(A. ROMITI, Archivistica Generale, Lucca, Civita Editoriale, 2011, pp.26-27)
Luciana Duranti (1997)
Si propone la definizione di archivio della Duranti perché introduce il documento digitale che ha suscitato nuove problematiche e sfide per la disciplina archivistica. Luciana Duranti è professoressa di Scienze archivistiche e diplomatiche presso la School of Library, Archival and Information Studies, University of British Columbia di Vancouver.
<<[L’archivio è] l’insieme dei documenti, senza riguardo alla forma o al supporto, automaticamente ed organicamente creati e/o accumulati ed usati da un particolare individuo, famiglia o ente nel corso delle sue attività e funzioni […]. Insieme delle informazioni scritte (o in qualunque altro modo connesse ad un supporto fisico) generate o ricevute da una persona fisica o giuridica come strumento e residuo della conduzione dei suoi affari.>>.
Sergio Pagano (1998)
Mons. Sergio Pagano è Prefetto della Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica e la definizione di archivio da lui formulata è anche quella ufficialmente adottata dalla Scuola.
<<L’archivio è l’insieme degli scritti di qualsiasi forma, contenuto e supporto materiale, ricevuti, redatti o comunque acquisiti da un ente (persona giuridica, persona fisica, associazione di fatto) nel corso della propria attività, i quali, per la loro natura e per il vincolo necessario che li lega, sono destinati ad essere conservati presso di esso.>>.
Conseil International des Archives (2000)
Concludo con la definizione di fondo archivistico secondo le Norme ISAD (G) [2000]
<<Fondo = L’insieme organico dei documenti archivistici, senza distinzione di tipologia o di supporto, formati e/o accumulati e usati da una determinata persona o ente nello svolgimento della propria attività personale o istituzionale.>>.